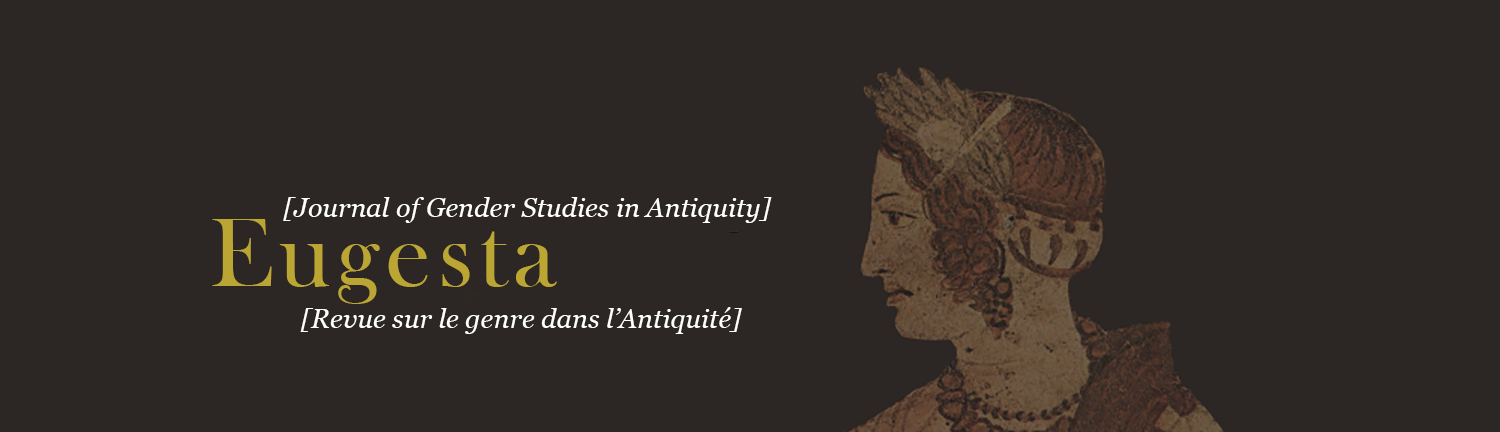1. Introduzione
È noto come, nel quadro concettuale della società romana, la sessualità femminile assumesse un valore positivo solo se canalizzata in una direzione socialmente efficace per il sistema patriarcale, ovvero nell’adempimento soddisfacente dei doveri coniugali e riproduttivi1. Le donne sessualmente libere erano poste ai margini: dislocate da una posizione centrale sotto il profilo pubblico, a causa della loro condotta indipendente e disinibita erano considerate elementi destabilizzanti per l’intero ordine sociale e politico, da stigmatizzare e isolare.
Attraverso la sua legislazione etico-matrimoniale2, Augusto scelse di esplicitare giuridicamente l’esistenza di precisi modelli di comportamento già radicati a fondo nella coscienza sociale, con l’obiettivo, di fatto, di concretizzare l’ideale della materfamilias romana consacrato anche dalla tradizione letteraria ed epigrafica3. All’interno di tale tradizione, oltre al peculiare legame con la domus4, motivo d’elogio per una donna era innanzitutto l’aver saputo rivestire degnamente i ruoli che nel mondo antico erano connessi in modo statutario con la femminilità, quello di moglie e di madre5. Al modello culturale e antropologico della matrona virtuosa e morigerata il princeps cercò dunque di dare nuovo vigore, fornendo una veste formalmente nuova, dotata di carattere di cogenza, a principi nient’affatto straordinari, da lungo tempo parte della mentalità repubblicana6.
Proprio il ricorso a un atto legislativo positivo per il ripristino del mos maiorum per quanto concerne la sfera della sessualità e dei rapporti coniugali risulta senz’altro uno degli elementi più eclatanti dell’intervento normativo: per cogliere l’audacia dell’iniziativa augustea, dunque, non è necessario accogliere l’interpretazione a tinte fosche che ne dà Tacito, attento a rimarcarne le successive degenerazioni legate al sistema delatorio7, ma è sufficiente pensare alla dimensione squisitamente orale in cui si sviluppava a Roma il mos maiorum8. Nelle Res Gestae il carattere innovatore della legislazione, come sempre bilanciato dall’ossequio formale della tradizione9, è del resto rimarcato dallo stesso Augusto10, attento altresì a rivendicarne la paternità politica: i provvedimenti in cui si articolava la riforma etico-matrimoniale comprendevano in effetti due plebisciti presentati personalmente dal princeps in virtù dei suoi poteri magistratuali, e una legge consolare che, pur proposta ufficialmente dai consoli suffetti Marco Papio Mutilo e Quinto Poppeo, aveva sempre in Augusto il suo effettivo promotore.
Attraverso la lex Iulia de maritandis ordinibus del 18 a.C. veniva stabilito l’onere del matrimonio o il vincolo del fidanzamento per tutti gli uomini tra i 25 e i 60 anni e per tutte le donne dai 20 ai 50 anni11. La successiva lex Papia Poppaea nuptialis intendeva invece perfezionare e intensificare gli effetti della lex Iulia, senza tuttavia alterarne la natura12: oltre a quello matrimoniale, evidentemente ritenuto insufficiente al perseguimento degli scopi demografici, venne introdotto anche l’obbligo della filiazione. Le prescrizioni erano temporaneamente sospese per le vedove e per le divorziate, che in base alla lex Iulia avevano rispettivamente un anno o sei mesi di tempo prima di dover contrarre nuove nozze. La lex Papia intervenne successivamente a mitigare la severità della prescrizione, concedendo un ulteriore anno di vacatio alle une e alle altre13. Si stabilivano inoltre criteri assai stringenti per la contrazione di iustae nuptiae e la procreazione di figli legittimi: ai senatori e alla loro discendenza, sia maschile che femminile, in linea retta maschile entro il terzo grado era infatti proibito il matrimonio o il fidanzamento con libertini e libertine, nonché con quanti facessero teatro o discendessero da essi14; agli ingenui, invece, era vietato sposare prostitute ed ex-prostitute, mezzani e mezzane e anche adultere condannate o colte in flagrante15. Funzionale alla salvaguardia della dignità sociale della famiglia, infine, era anche la lex Iulia de adulteriis. Approvata su proposta dello stesso Augusto all’inizio dell’estate del 17 a.C.16, la sua emanazione segnava invece per la prima volta un intervento diretto da parte della res publica nella repressione dei reati sessuali, rimessa fino a quel momento all’iniziativa familiare17.
Il fatto che i contenuti della legislazione siano accessibili allo studioso moderno solo attraverso un’attenta opera di ricostruzione, svolta a partire da una letteratura giuridica seriore di almeno due secoli, rende naturalmente molto complessa un’esatta valutazione della normativa, inibendo di fatto una piena comprensione dei suoi scopi18. Ciò nonostante, da un lato è indubitabile che nelle intenzioni del princeps le prescrizioni rispondessero a un’esigenza di risanamento della società tanto sul piano demografico19 che su quello morale, perseguito non attraverso un corpus normativo unitario e coerente20 ma, come confermano anche recenti ritrovamenti epigrafici, con un programma di riforme complesso, articolato e non privo di aspetti sperimentali21, il cui percorso fu peraltro segnato da cocenti insuccessi e battute d’arresto22; dall’altro, traspare un secondo eclatante elemento di novitas che contraddistingue la normativa, ossia la rilevanza attribuita alla figura femminile, dotata istituzionalmente di una centralità sociale assolutamente priva di precedenti. Il dato risulta ampiamente acquisito dalla critica23. Tuttavia, una lettura troppo spesso ancorata in modo esclusivo agli scopi demografici e moralizzatori sottesi alle leggi ha inibito, a mio avviso, la valorizzazione di uno degli elementi più marcatamente originali dell’iniziativa di Augusto24: l’attenzione riservata alla donna non solo in quanto uxor25 e mater26, ma anche in qualità di domina, titolare di diritti patrimoniali. In che modo, dunque, è possibile procedere a una riconsiderazione in chiave economico-giuridica della rilevanza attribuita dal princeps all’elemento femminile?
In primo luogo, attraverso una disamina puntuale della normativa. Solo entrando nel merito dei contenuti della legge, infatti, e in particolare attraverso l’analisi del complesso sistema di privilegi e sanzioni da essa previsto27, è davvero possibile provare a valutare non solo l’entità del coinvolgimento femminile nel programma del princeps, ma anche sotto quali aspetti quest’ultimo possa aver sancito un turning-point per la condizione economico-giuridica delle donne.
Da questo punto di vista, è opportuno esplicitare fin d’ora il quadro di riferimento delle osservazioni che seguiranno. Com’è noto, quella di “condizione della donna romana” è una perifrasi generalista, potenzialmente inclusiva di una molteplicità di posizioni delle quali non è possibile dar conto unitariamente28. Se il programma di risanamento della società propugnato dalla legislazione augustea prevedeva senza dubbio il coinvolgimento dell’intero corpo civico29, va rimarcato che non mancano gli indicatori di un interesse preminente per i membri dell’ordine senatorio, equestre e decurionale, destinati a costituire i ranghi dell’amministrazione della nuova compagine imperiale30. In questa sede, nello specifico, l’attenzione sarà dunque concentrata sui provvedimenti rivolti alle ingenuae, con particolare riguardo alle appartenenti all’élite non solo economica ma anche politica dell’impero31.
Tuttavia, una disamina puntuale dei contenuti della normativa, pur indispensabile, non è a ogni modo sufficiente per valutarne criticamente gli aspetti innovatori in tema di status femminile32. Solo contestualizzando adeguatamente il dato giuridico da un punto di vista storico, infatti, la legislazione e il complesso quadro di privilegi e sanzioni da essa stabiliti acquistano pregnanza di significato. Nella seconda parte del lavoro si procederà pertanto a una considerazione del quadro storico, sociale ed economico in cui è maturato il disegno normativo, nel tentativo di leggere la riforma etico-matrimoniale di Augusto al di là dell’innegabile valore ideologico che la contraddistingue.
2. I contenuti della legislazione: un’analisi in prospettiva di genere
Il complesso quadro di sanzioni e privilegi con cui Augusto aveva corredato la normativa aveva un carattere prevalentemente economico e prevedeva un’esplicita inclusione delle donne al suo interno. A essere colpita o valorizzata, in definitiva, era anche la capacità patrimoniale femminile, non certo un elemento di recente acquisizione, ma, secondo l’opinione maggioritaria tra gli studiosi, un dato presente fin dalle più remote origini nell’esperienza giuridica romana33. Titolari in prima persona di diritti patrimoniali erano naturalmente solo le donne che non erano sottoposte né alla potestas paterna, né alla manus del marito, ovvero quante si trovavano nella condizione di sui iuris. Alla fine della Repubblica l’entità numerica di queste ultime, data l’associazione tra il peculiare regime demografico vigente nel mondo romano e la progressiva decadenza del matrimonio cum manu34, era assolutamente cospicua, giustificandone appieno l’inclusione nel quadro normativo elaborato dal princeps35.
Se i beni accumulabili attraverso la successione ereditaria costituivano senza dubbio la più consistente tra le voci che concorrevano a formare l’attivo patrimoniale di una donna, elementi di rilievo erano anche le ricchezze acquisibili grazie all’attività negoziale, e la dote36. I meccanismi di coercizione stabiliti dalla normativa interferivano in modo più o meno rilevante con tutte e tre queste componenti della ricchezza femminile (hereditas, negotia, dos), dimostrando a chiare lettere come un presupposto fondamentale di tale ricchezza fosse costituito dalla capacità patrimoniale delle donne, un elemento al quale Augusto, rispettati determinati requisiti, conferì riconoscimento e tutela.
2a. Sanzioni
Le sanzioni previste dalla legislazione riguardavano indistintamente donne e uomini37 e intervenivano principalmente in materia di diritto di successione38. La successione ab intestato, rara ma comunque vigente a quest’epoca, non veniva in alcun modo intaccata dalle disposizioni augustee, che interessavano esclusivamente la trasmissione testamentaria dei beni39. Quest’ultima estendeva le possibilità di successione ben oltre l’ambito familiare: in presenza di una fitta rete di rapporti amicali e patronali, i testamenti contribuivano infatti a una circolazione della ricchezza anche in senso orizzontale40. Proprio in questa prassi intendeva intervenire la normativa del princeps, che non mirava a colpire i diritti ereditari all’interno della famiglia41, ma contrastava piuttosto la crescente propensione ad assegnare cospicue porzioni del patrimonio a individui estranei alla cerchia più strettamente familiare42. Una tendenza, quest’ultima, destinata ad accentuarsi pericolosamente in assenza di prole legittima e che andava invece limitata in favore della stabilità patrimoniale della famiglia, soprattutto in fase di consolidamento del nuovo regime istituzionale.
Le donne che non ottemperavano ai requisiti previsti dalla legge vedevano pesantemente intaccata la loro capacità ad acquistare per testamento. Stando alla testimonianza offerta nel II sec. d.C. dal giurista Gaio, la lex Iulia de maritandis ordinibus proibì a coloro che tra i 20 e i 50 anni non fossero sposate o fidanzate, o quantomeno non si impegnassero a farlo entro 100 giorni, di accettare eredità e legati43. La successiva lex Papia impose che le coniugate senza figli potessero ricevere solo la metà dell’eredità e dei legati, nel caso questi fossero stati disposti in loro favore da estranei44; solo uno o più decimi del patrimonio ereditario, invece, da parte del coniuge, in assenza di figli in comune45. Per il solo fatto di essere sposati i coniugi potevano ricevere un decimo dell’eredità, e aggiungere ad essa tante decimae quanti erano i figli superstiti da precedenti matrimoni, o precocemente deceduti nel corso dell’unione con il defunto46. Inoltre, alla moglie priva di figli in comune con il marito, ma a lui legata da un matrimonium iustum, era assegnato l’usufrutto sulla terza parte dei beni ereditari, destinato a tramutarsi in piena proprietà solo nell’eventualità di figli nati da nuove nozze47.
Non deve sorprendere che la posizione successoria della donna nei confronti del marito fosse penalizzata in misura maggiore rispetto a quella verso un estraneo. Il fatto, paradossale per la sensibilità moderna, va considerato nel quadro più generale della rigida separazione dei beni caratteristica del matrimonio sine manu d’età classica, perseguita anche attraverso il divieto di donazioni reciproche tra i coniugi previsto dall’ordinamento48. La limitazione della liberalità tra marito e moglie49 era infatti funzionale alla salvaguardia del patrimonio familiare: si evitava così che la ricchezza della famiglia d’origine fosse diminuita a favore di quella del coniuge, e se ne preservava l’integrità a vantaggio dei discendenti. Solo la presenza di un nuovo nucleo familiare in cui far confluire i beni di entrambi gli sposi giustificava che si intaccasse in qualche modo l’integrità patrimoniale delle famiglie di appartenenza; di qui l’importanza assunta dalla presenza di figli, che qualificava pertanto la maternità e la paternità come condizioni legittimanti per l’acquisizione della piena facoltà a capere per testamento.
A ogni modo, pur mantenendo una loro validità giuridica50, le unioni vietate non erano utili per conferire una piena capacità testamentaria: esse risultavano infatti irrilevanti ai fini della legge, così come lo era la prole da esse nata. Esattamente come per i padri, che potevano far valere solo i figli nati da un’unione che rispettasse i requisiti imposti dalla lex Iulia e dalla lex Papia51, anche le madri potevano includere nel computo solo i figli nati da un iustum matrimonium52.
Dal quadro appena tratteggiato emerge tuttavia un ulteriore elemento degno di nota. Nel programma legislativo di Augusto, in tutta evidenza, le donne non erano coinvolte solo in qualità di destinatarie, ma anche come agenti della trasmissione. Uno dei presupposti della normativa era infatti costituito dalla capacità muliebre a trasmettere per testamento (testamenti factio attiva). In effetti, oltre a beneficiare in prima persona delle ultime volontà di padri, mariti, amici, e liberti, le donne, soddisfatti determinati requisiti giuridici, erano esse stesse testatrici53. Pur attestati in percentuale minoritaria rispetto a quelli maschili, i testamenti femminili rappresentavano un fenomeno piuttosto diffuso54, espressione da un lato dell’identità della defunta e delle relazioni che aveva saputo stringere in vita, dall’altro concretizzazione sul piano patrimoniale del legame verso la prole considerata, secondo una concezione radicatissima nella coscienza sociale romana, destinataria precipua delle sostanze materne55. Il testamento non costituiva dunque solo un supremum iudicium, attraverso il quale la testatrice esprimeva le proprie ultime volontà, ma anche un officium, e in particolare un officium pietatis56. Una conferma in questo senso è rintracciabile all’interno di un episodio narrato in età tiberiana da Valerio Massimo, dove si riscontra un intervento straordinario dello stesso Augusto57. Una certa Septicia, madre dei Tracali di Rimini, decise di nominare erede delle proprie sostanze il marito Publicio, ormai attempato, estromettendo invece ingiustamente i figli di primo letto. Anche se le nozze non contravvenivano alla legislazione58, andavano di certo contro il suo spirito. Il princeps, non a caso, chiamato in causa proprio dai Tracali, intervenne personalmente disapprovando sia le nozze, sia le ultime volontà (suprema iudicia) della donna. Dispose inoltre che l’eredità materna fosse assegnata ai figli, privando al contempo il marito della possibilità di conservare la dote59. Pur nella concisione e nella mancanza di rigore tecnico tipiche del racconto aneddotico60, l’episodio fornisce elementi preziosi per tentare di precisare quale ruolo Augusto intendesse assegnare all’elemento femminile nel suo programma legislativo: la capacità economica della donna doveva risultare funzionale in primis alla stabilità patrimoniale della famiglia e al benessere della prole legittima; quando non era utile a questo scopo, invece, essa era soggetta a pesanti limitazioni.
Da questo punto di vista, non stupisce che in base alla lex Iulia e alla lex Papia titolari di una capacitas solo parziale fossero anche le adultere (feminae probrosae)61, la cui prole era considerata irrilevante ai sensi della politica demografica augustea. Ulteriori rigide sanzioni patrimoniali per questa categoria di donne erano poi previste anche dalla lex Iulia de adulteriis. L’adultera colta in flagranza di reato o condannata dal tribunale competente istituito dalla legge, infatti, oltre alla relegatio in insulam e ad altre penalizzazioni sul versante pubblico62, non solo perdeva metà della dote – privata della sua utilità, dal momento che all’adultera era impedito di contrarre un nuovo matrimonio63 − ma subiva anche la publicatio di una parte consistente dei suoi beni, un terzo dei quali era destinato alla cassa pubblica64.
2b. Privilegi: il ius liberorum
La legislazione, a ogni modo, non si limitava a contemplare rigide restrizioni in termini di libertà testamentaria, ma prevedeva altresì importanti privilegi per quante si attenessero alle sue disposizioni. A Roma il principale proposito dell’istituto matrimoniale era proprio la procreazione, come denota l’insistenza con cui le fonti associano il matrimonio alla formula liberorum quaerundorum causa, parte integrante del giuramento che il cittadino doveva prestare dinanzi al censore65. Già Cicerone legava le sorti della res publica alla filiazione, invitando i governanti all’adozione di specifici provvedimenti per incentivarla66, e tentativi di incoraggiamento in tal senso sono in effetti testimoniati già dalla politica agraria dei Gracchi e in età cesariana: le leggi Giulie del 59 a.C. attribuivano ai padri di almeno tre figli una posizione privilegiata nell’assegnazione dell’ager campanus, così come nel 46 a.C. furono offerti dei premi a chi generava più figli67. Se per certi aspetti, dunque, Augusto di fatto non fece che riprendere l’iniziativa avviata dal padre adottivo, facendone un vero e proprio tratto distintivo della propria politica68, tale ripresa si accompagnò tuttavia a un’importante innovazione. Accanto ai privilegi associati alla paternità, fin dalla lex Iulia de maritandis ordinibus69 furono infatti previste specifiche ricompense anche per lo status di mater, afferenti però, diversamente da quelle attribuite al genitore di sesso maschile, a una dimensione eminentemente privatistica70. Va notato che nel quadro dei privilegi che la legislazione assegnava alla materfamilias in virtù della prole71 sembra possibile distinguere due diverse accezioni del ius liberorum72: da un lato, il ius trium liberorum, attribuito singolarmente all’ingenua che avesse partorito tre figli73; dall’altro, il ius communium liberorum, assegnato invece congiuntamente ai coniugi che ne facessero richiesta e avessero un figlio in comune. In entrambi i casi, peraltro, oltre che per merito, tale ius poteva essere ottenuto anche graziosamente74, a titolo temporaneo o permanente.
Per quanto concerne il ius trium liberorum, i benefici a esso collegati si esplicavano per le donne su tre diversi fronti. Innanzitutto, le patrone e le discendenti femminili del patrono che fossero liberis honoratae videro aumentati i loro diritti nella successione ai liberti75. Com’è noto, questi ultimi mantenevano con i loro patroni uno stretto legame morale, sociale ed economico: nella ridefinizione dei rapporti conseguente alla manomissione, la costruzione pseudo-filiale della relazione tra liberto e patrono offriva infatti a quest’ultimo anche dei vantaggi economici, per esempio in termini di aspettative ereditarie sulle proprietà dei suoi ex-schiavi76. Il principio, presente già nelle Dodici Tavole, fu implementato dal diritto pretorio, in virtù del quale al patrono fu permesso di ottenere la metà del patrimonio non solo del liberto morto senza fare testamento e privo di figli naturali, ma anche in caso di successione testamentaria, purché l’eredità fosse stata assegnata a un extraneus o a un erede non naturale. Si trattava di una possibilità del tutto preclusa alle donne, ed estesa invece ad alcune di loro grazie alla normativa di Augusto. Proprio a partire soprattutto dall’età augustea lo status di patrona risulta ampiamente attestato sul suolo italico e provinciale: anche le donne infatti, se sui iuris, potevano essere dominae di schiavi ed emancipatrici77. Con la lex Papia Poppaea, dunque, contestualmente a un aumento delle prerogative del patrono78, venne sancita una modifica del regime a favore della patrona che fosse madre. Le successioni interessate dalla nuova regolamentazione erano esclusivamente quelle nei confronti dei liberti locupletiores, e in particolare di quelli centenarii, ovvero di quanti lasciavano un patrimonio valutabile in 100.000 o più sesterzi79. All’ingenua madre di due figli furono attribuiti gli stessi diritti previsti dall’editto del pretore per il patrono; la patrona madre di tre, invece, vide la propria posizione equiparata a quella sancita per il patrono dalla lex Papia, avendo diritto a una quota dei bona libertorum anche in presenza di eredi naturali80. Trattandosi di diritti trasmissibili, i benefici introdotti dalla lex Papia furono estesi anche al figlio della patrona – purché avesse a sua volta almeno un figlio o una figlia – nonché alle discendenti del patrono in linea maschile fino al terzo grado: figlie, nipoti e pronipoti del patrono dotate di ius trium liberorum, grazie alla lex Papia, videro dunque la loro posizione successoria nei confronti dei bona dei liberti equiparata a quella del patrono e dei discendenti di sesso maschile81.
In secondo luogo, mediante il ius trium liberorum, alle ingenuae venne concessa l’esenzione dalla tutela muliebre82. Il diritto romano classico prevedeva che la donna sui iuris fosse soggetta a tutela per l’intero corso della propria esistenza83. Con la sola eccezione delle vergini Vestali84, tutte le donne erano quindi sottoposte a un certo grado di limitazione nella possibilità di agire, necessitando dell’assenso del tutore per il compimento degli atti di maggior rilevanza patrimoniale85. Per alienare fondi o edifici siti su suolo italico, schiavi, animali che potevano essere domati sul collo o sul dorso o servitù prediali, oppure per manomettere uno schiavo, assumere obbligazioni contrattuali, costituire una dote, stipulare un matrimonium cum manu, o accettare un’eredità che poteva essere gravata da debiti una donna non poteva in alcun modo prescindere dall’assistenza del tutore. Sebbene la critica abbia persuasivamente ridimensionato l’effettiva incidenza dell’istituto alla fine dell’età repubblicana86, in relazione alla tutela l’attività legislativa del princeps assunse i connotati di un vero e proprio spartiacque: non solo contribuì in modo decisivo al progressivo affievolimento del valore della tutela, destinata a subìre di lì a pochi decenni un ulteriore contraccolpo con la definitiva abolizione della tutela legittima a opera di Claudio, ma riconobbe alle cittadine sui iuris una possibilità in precedenza non prevista dall’ordinamento romano. Sotto questo profilo, assicurando alle donne titolari del ius una sostanziale autonomia nella gestione del patrimonio, la liberazione dalla tutela rappresenta senz’altro uno dei progressi più significativi per la condizione economico-giuridica femminile87. Notevole, peraltro, che subordinando l’esenzione al rispetto di un requisito di prolificità, il conferimento del privilegio sconfessi apertamente la pretesa dell’infirmitas sexus a porsi quale criterio giustificativo reale dell’istituto tutelare88.
Infine, al ius trium liberorum già la lex Iulia associava vantaggi in termini di facoltà a ricevere per testamento (capacitas). La madre di tre o più figli godeva di capacitas completa e non era dunque soggetta a particolari restrizioni nell’acquisizione di lasciti testamentari, anche se da un lato è incerto come la normativa augustea si sia armonizzata con la lex Voconia, la quale poneva severe limitazioni ai quantitativi di ricchezza che una donna poteva ricevere da un cittadino della prima classe di censo89; dall’altro, se il testatore era marito della donna, sembra che nei confronti di quest’ultimo la posizione successoria della moglie fosse caratterizzata da una maggiore complessità. Non risulta, infatti, che il ius trium liberorum, fosse stato esso attribuito per merito o esito di una concessione, fosse in sé sufficiente ad assicurare a una donna la piena libertà di ricevere quanto lasciato dal consorte: la presenza di tre figli superstiti da precedenti unioni, di per sé, dava alla uxor la possibilità di ottenere al massimo i tre decimi dei bona maritali90. Solo la presenza di figli in comune con il coniuge conferiva alla moglie la piena capacità di ricevere anche nell’ambito della successione reciproca all’interno della coppia. Nello specifico, era sufficiente un solo figlio in comune affinché un coniuge potesse ereditare per intero quanto lasciato dall’altro per testamento91. La legge teneva peraltro in debita considerazione l’alto tasso di mortalità infantile, visto che nel computo avevano rilevanza anche i figli morti: si otteneva la capacitas completa sia con un unico figlio comune morto dopo la pubertà, sia nel caso in cui fossero morti due figli impuberi maggiori di tre anni, sia nell’eventualità che i coniugi avessero perso tre figli, purché avessero raggiunto il dies nominis92 e fossero stati comuni93. L’incoraggiamento del legislatore all’incremento demografico non era dunque indiscriminato, ma sembrava in qualche modo tener conto sia delle reali possibilità di sopravvivenza della prole, sia dell’esigenza di non frammentare eccessivamente la proprietà, contrastando al tempo stesso la tendenza a lasciarla al di fuori della famiglia94.
È dunque grazie al ius communium liberorum che lo status sociale e patrimoniale delle mogli degli appartenenti alla prima classe di censo vide un sensibile miglioramento. La posizione successoria di queste ultime in precedenza era infatti regolata dalla lex Voconia del 169 a.C.: emanata con il sostegno di Catone il Censore in un momento di particolare dinamismo sul piano sociale ed economico, il plebiscito vietava ai cittadini iscritti nella prima classe di censo di nominare erede una donna, concedendo a quest’ultima un lascito di valore non superiore a quanto destinato agli eredi veri e propri95. Nella migliore delle ipotesi, dunque, alla uxor era consentito ricevere, al più, metà della proprietà del coniuge in qualità di legataria96. Il provvedimento, funzionale a garantire che il titolo di erede e la parte più considerevole dei beni dei membri della prima classe di censo si trasmettessero in linea maschile, evitando altresì un’eccessiva frammentazione del patrimonio, poteva condizionare piuttosto negativamente i rapporti patrimoniali tra coniugi. Con la concessione del ius communium liberorum, la lex Papia Poppaea esentò la moglie di un classicus che avesse almeno un figlio in comune con il marito dall’applicazione del plebiscito, implementando dunque notevolmente i diritti ereditari di quest’ultima nell’ambito della coppia: tra le disposizioni riportate da Cassio Dione troviamo infatti pure quella che consentì ad “alcune donne” (γυναικῶν τισι) di “ereditare” (κληρονομεῖν) anche contro il divieto imposto dalla lex Voconia97.
A differenza del ius trium liberorum, che incideva solo sulla possibilità di acquisire per testamento (capacitas), il ius communium liberorum interveniva dunque sull’idoneità a essere istituiti eredi (testamenti factio passiva) e, mentre in relazione alla capacitas la posizione matrimoniale o genitoriale era considerata alla morte del testatore o anche successivamente (rilevante era infatti il momento dell’acquisto), la testamenti factio doveva sussistere già al momento della confezione del testamento98. La distinzione tracciata tra ius trium liberorum e ius communium liberorum aiuta peraltro a comprendere la peculiare posizione successoria di Livia rispetto ad Augusto. Stando a Cassio Dione, per ottenere la facoltà di nominare la consorte erede di un terzo suoi beni, il princeps dovette premurarsi di richiedere per sé e la moglie una dispensa senatoria dai divieti sanciti dalla lex Voconia99. Nonostante Livia fosse in possesso del ius trium liberorum già dal 9 a.C., dopo che le era stato attribuito dal senato in seguito alla morte del figlio minore Druso100, la mancanza di un figlio in comune incideva evidentemente sulla testamenti factio della coppia, costringendo Augusto a sanare la propria posizione e quella della consorte già nel momento in cui si apprestava a redigere le sue ultime volontà.
In definitiva, il ius communium liberorum aveva un ambito d’applicazione più esteso rispetto al ius trium liberorum: garantiva tutti i vantaggi previsti per i genitori di tre figli e in più aveva rilevanza nell’ambito della successione reciproca all’interno della coppia, risultando particolarmente prezioso per le consorti dei cittadini appartenenti alla prima classe di censo. Pur lasciando in vigore il plebiscito Voconio, Augusto migliorò notevolmente la posizione sociale e patrimoniale della moglie che avesse dato dei figli al marito: al di là della dimensione economica della successione, infatti, l’esenzione dalla lex dischiudeva alla consorte la possibilità di essere titolare dell’eredità del coniuge101.
Le prerogative connesse al ius liberorum in ambito ereditario e in termini di capacità di agire dimostrano come con Augusto il valore sociale della maternità sia giunto a interferire con il piano normativo con risvolti di assoluta evidenza sul piano giuridico ed economico102. Sembra probabile che per le donne l’interesse a ottenere questo privilegio fosse tanto più vivo quanto maggiore era la posta in gioco in termini di prestigio familiare e ricchezze personali. L’esenzione dalla tutela doveva costituire un traguardo piuttosto ambito soprattutto dalle matronae più facoltose, capaci così di aumentare esponenzialmente le possibilità di arricchimento nell’ambito della successione nei confronti di amici, familiari e liberti e legittimate ufficialmente a gestire in sostanziale autonomia il loro patrimonio103.
2c. La dote
Le prescrizioni della normativa augustea non mancavano di contemplare anche un’altra componente fondamentale della ricchezza femminile, i beni dotali. Soprattutto per i ceti abbienti la dote a Roma non esplicava la propria rilevanza solo sotto il profilo strettamente finanziario, ma anche da un punto di vista sociale: sussisteva infatti una strettissima correlazione tra il matrimonio e la dote, essendo quest’ultima di fatto indispensabile per la contrazione delle nozze104. Naturale, dunque, che nel quadro di una politica volta all’incremento delle nozze il princeps abbia assunto un atteggiamento particolarmente favorevole verso la dos, inaugurando un percorso legislativo che vedrà una progressiva affermazione di quest’ultima quale istituto di pubblico interesse105.
In materia di dote la legislazione augustea si rivelò favorevole sotto un duplice profilo. In primo luogo, pose le premesse per l’introduzione di un obbligo giuridico per la sua costituzione: in base alla lex Iulia, infatti, il genitore delle figlie ancora sottoposte alla potestas poteva essere costretto dal pretore a prestare il suo assenso al matrimonio e a costituire la dote, mentre nel caso in cui il tutore di una donna sui iuris, a causa della minore età di lui, non avesse potuto consentirle la constitutio dotis, ostacolando dunque pesantemente la volontà di sposarsi, la donna aveva la facoltà di rivolgersi all’autorità competente per ottenere un altro tutore106.
In secondo luogo, si occupò anche di proteggerne la consistenza durante il matrimonio, in vista di un’eventuale restituzione. Infatti, se fin tanto che perdurava il legame coniugale spettava al marito l’amministrazione dei beni dotali, utili al sostenimento degli onera matrimonii107, al termine dell’unione su tali beni la moglie vantava precise aspettative di restituzione108. La precocità con cui a Roma tendenzialmente le donne si sposavano e rimanevano vedove, associata alla frequenza con cui si susseguivano divorzi e seconde nozze109 palesa a chiare lettere l’importanza cruciale di preservare il valore di questi cespiti, opportunamente tutelati dalla legislazione augustea. Rigide limitazioni ai poteri di gestione del coniuge, gestore fiduciario e responsabile dell’amministrazione dei beni dotali110, erano previste infatti dalla lex Iulia de maritandis ordinibus, nonché da un’apposita clausola della lex Iulia de adulteriis coercendis che, di poco posteriore alla prima, sarebbe intervenuta a precisarne ulteriormente le disposizioni111. In primo luogo, alla manomissione dello schiavo dotale il marito poteva procedere solo previo assenso della moglie112. Anche nel caso lo schiavo fosse stato manomesso voluntate mulieris, la moglie era d’altro canto legittimata a pretendere il valore in denaro dei diritti di patronato acquisiti in seguito all’operazione113. Una fonte postclassica, poi, attribuisce alla lex Iulia de adulteriis, che doveva contenere al suo interno un’intera sezione specificamente dedicata al tema114, anche l’introduzione in capo al marito del divieto di alienare il fondo dotale senza la volontà della moglie115. La legislazione augustea sancì pertanto un notevole miglioramento in ambito dotale: si crearono le condizioni affinché le donne fossero adeguatamente provviste di dote, nonché munite degli strumenti giuridici idonei al suo recupero. Quest’ultimo risultava essenziale non solo per garantire una certa autosufficienza in caso di vedovanza o divorzio, ma, soprattutto, per agevolare eventuali seconde nozze, in perfetta coerenza con l’incentivo alle unioni coniugali promosso dalla legislazione.
Una lettura analitica dei contenuti della normativa evidenzia dunque a chiare lettere come la capacità patrimoniale femminile fosse di fatto ostacolata solo in assenza di giuste nozze e di discendenti legittimi cui trasmettere il patrimonio. Al contrario, quand’era funzionale alla continuità e alla stabilità finanziaria della famiglia, alla ricchezza femminile il princeps sembra aver accordato un favore significativo, includendo specifiche disposizioni tese a tutelarne l’integrità, come dimostrano apertamente le norme in materia dotale, e un’amministrazione autonoma da parte delle donne, come evidenzia l’esenzione dalla tutela legata al ius liberorum. Subordinando al soddisfacimento di determinati requisiti matrimoniali e procreativi la possibilità di accumulo di ricchezza per via ereditaria e di una libera gestione della stessa, Augusto disciplinava dunque l’indipendenza patrimoniale femminile de facto esistente116, canalizzandola efficacemente nella direzione della continuità familiare. Posto che sarebbe senz’altro errato e anacronistico interpretare la sua iniziativa in chiave “femminista”117, resta da chiedersi quali ragioni indussero Augusto a valorizzare in modo tanto macroscopico la capacità patrimoniale delle donne che, pur affermata a livello fattuale già negli ultimi secoli della Repubblica, trovò indiscutibilmente nella legislazione un importante riconoscimento normativo.
2d. La trasmissione del patrimonio familiare tra sfera privata e rilevanza pubblica
Il sistema sanzionatorio con il quale Augusto scelse di corredare la sua riforma etico-matrimoniale dimostra come quest’ultima, oltre che un potentissimo manifesto ideologico, si configurasse come una risposta molto pragmatica a un problema certamente non nuovo per la società romana, e da sempre guardato con una certa apprensione: quello della trasmissione del patrimonio all’interno della famiglia. Dato che una delle funzioni fondamentali dell’istituto matrimoniale, almeno tra i ceti agiati, consisteva indubbiamente nell’agire quale veicolo per la trasmissione della proprietà di generazione in generazione, il ripristino della morale familiare e la presenza di una discendenza legittima avrebbero avuto di certo conseguenze inestimabili sulla stabilizzazione della trasmissione della proprietà e dello status. Si trattava in tutta evidenza di processi di rilevanza cruciale, soprattutto nel quadro di un assetto istituzionale e amministrativo ancora in fase di consolidamento118.
Una sensibilità per questa tematica da parte del princeps risulta in effetti ampiamente attestata. A fronte di una sempre più diffusa propensione da parte dei privati a citare l’imperatore all’interno dei loro testamenti, in presenza di eredi naturali Augusto era solito rifiutare con decisione eventuali legati o quote ereditarie a lui assegnati, preferendo invece restituirli ai naturali destinatari, talora rimpinguando addirittura le somme di tasca propria119. Già attraverso la propria condotta personale, dunque, egli si adoperò concretamente per rinvigorire la morale testamentaria dei cittadini: a quest’ultima, non del tutto assente nella coscienza sociale del tempo, Augusto riteneva che non si potesse concedere alcuna deroga. Del resto, fatte salve le incertezze relative all’esatta cronologia del discorso augusteo e all’originalità dei suoi contenuti120, anche nelle parole a lui attribuite da Cassio Dione e pronunciate nella primavera del 9 d.C. dinanzi a senatori e cavalieri121, il princeps non solo avrebbe enfatizzato i vantaggi che l’incremento demografico avrebbe determinato sul piano pubblico, ma avrebbe posto l’accento anche sulle conseguenze positive a livello privato, per la continuità della trasmissione patrimoniale122.
In una società timocratica come quella romana, dove il censo rappresentava un criterio dirimente nell’articolazione e nella classificazione del corpo civico a scopi politici, la trasmissione della ricchezza non poteva tuttavia costituire un fatto esclusivamente privato. E ciò tanto meno in un frangente delicato come quello in cui, con ogni probabilità, Augusto avviò l’elaborazione della sua riforma etico-matrimoniale. A differenza di quanto comunemente riportato dalla manualistica, è stata avanzata l’ipotesi che la stesura di un primo progetto, reso noto e poi ritirato a causa della dura opposizione incontrata, possa ascriversi già al 28-27 a.C.: il momento in cui il princeps avrebbe avviato il suo programma andrebbe dunque retrodatato in modo significativo negli anni immediatamente successivi alla fine delle guerre civili, evento a cui sarebbe legato da un nesso non solo cronologico ma anche causale123. Una consequenzialità sottolineata in età tiberiana anche da Velleio Patercolo, il quale colloca le fasi iniziali dell’attività legislativa di Augusto proprio finita vicesimo anno bella civilia: l’urgenza di una rigenerazione nella morale e nel diritto avrebbe condotto il princeps a ridare vigore alle leggi, correggendone alcune e proponendone con profitto altre124. Degno di nota, peraltro, che all’interno del catalogo degli effetti benefici prodotti dagli interventi augustei, Velleio menzioni dapprima la securitas, uno dei pilastri su cui si fondava il Principato e, assieme alla pax, uno dei valori sbandierati a livello propagandistico già all’indomani della vittoria contro Sesto Pompeo125, ma subito dopo insista anche sulla certa cuique rerum suarum possessio126. La certezza della proprietà dovette costituire una vera e propria priorità dell’agenda politica e uno dei fondamenti del nuovo ordine costituzionale: per dotare di una solida base sociale ed economica il nuovo regime e, al contempo, per arginare il disorientamento e lo sconcerto nei quali era piombata la collettività negli anni delle proscrizioni, dei quali peraltro era stato egli stesso fautore, Ottaviano si preoccupò innanzitutto della ricostituzione e della protezione degli equilibri in ambito proprietario.
La scelta di includere a pieno titolo l’elemento femminile nel complesso quadro di praemia et poenae a carattere economico previsto dalla legislazione potrebbe dunque interpretarsi alla luce di un più ampio interesse del princeps per la stabilizzazione della proprietà: Augusto probabilmente comprese che per la restitutio della res publica127 un apporto di non secondaria importanza poteva essere fornito dalle donne, garanti della continuità familiare non solo sul piano biologico, sociale e valoriale ma anche sotto il profilo più schiettamente patrimoniale128.
Per valutare adeguatamente la normativa, pertanto, è opportuno riflettere sulle circostanze che avevano condotto il triumviro, prima ancora che il princeps, a prestare alla capacità patrimoniale delle donne una tale attenzione.
3. I prodromi della legislazione augustea
3a. L’impatto delle proscrizioni sulla classe dirigente: risvolti sociali e patrimoniali
Il 27 Novembre 43 a.C. la lex Titia istituiva il triumviratus rei publicae constituendae e ne sanciva quale primo provvedimento l’eliminazione fisica degli oppositori129. Oltre all’indubitabile turbamento sul piano valoriale, le proscrizioni determinarono sconvolgimenti profondissimi a livello sociale e patrimoniale130. L’organigramma delle élites ne risultò letteralmente decimato. Sulle liste, infatti, era presente circa un terzo del senato131 e, su un corpo civico già oltremodo provato dalle guerre civili, l’impatto dovette senza dubbio essere dirompente: le vittime designate coincidevano infatti con gli esponenti più illustri della classe dirigente, individui prominenti tanto sotto il profilo politico che sotto quello economico132. Le esecuzioni erano peraltro accessibili a chiunque desiderasse partecipare a questa sorta di massacro legalizzato133: erano infatti previste specifiche ricompense per la consegna della testa del proscritto, esposta al Foro quale pubblica testimonianza dell’efficacia delle disposizioni dei triumviri134.
Ma gli effetti delle proscrizioni non si limitavano né alla dissoluzione di ogni legame di solidarietà né alla pena capitale. Per il proscritto la morte fisica costituiva di fatto solo l’epilogo di una cancellazione sul piano sociale operativa già con l’inserimento del suo nome nelle πίνακες: la dichiarazione di hostis rei publicae e la publicatio bonorum trasformavano infatti il nemico di parte in nemico dello Stato, sottraendo arbitrariamente a ogni tipo di tutela la persona fisica e i bona di chi rientrava nelle liste, costretto alla fuga e a un’esistenza da fuorilegge, nonché privato integralmente dei propri beni135. Le proscrizioni e le confische avevano dunque completamente scardinato il principio della legittima proprietà136, non solo rivoluzionando i possessi, ma turbando nel profondo le coscienze, e si prestavano quindi ad essere interpretate dalla società romana come mezzo di rivolgimento sociale e di violenta redistribuzione della ricchezza137.
D’altro canto, oltre che sulla gravità del dissesto sociale, politico ed economico, le fonti convergono su un ulteriore punto. Tanto Appiano quanto Cassio Dione riportano che tra i proscritti un gran numero non solo si salvò e fece ritorno in patria, ma alcuni ottennero anche cariche pubbliche138. L’arbitrarietà del potere triumvirale trovava una concreta manifestazione proprio nelle liste di proscrizione139, suscettibili di continue modifiche e aggiornamenti in senso inclusivo ed esclusivo140. Non mancarono, dunque, casi di restitutiones, effettuate in modo più o meno formale sia ad hominem sia collegialmente141: attraverso alcuni reintegri individuali, o attraverso l’amnistia di carattere generale decretata dagli accordi di Miseno, si permise a un numero non irrilevante di proscritti non solo di sopravvivere, ma anche di reintegrarsi nel corpo politico142.
Quella che si affermò dopo Azio, in effetti, fu un’aristocrazia profondamente rinnovata, i cui membri in parte avevano supportato Ottaviano già fra il 36 e il 32 a.C., in parte avevano beneficiato di riabilitazione dopo il 31143. Già nel 29 a.C. il princeps aveva condotto una prima lectio del senato, espellendone i vari membri indegni o scomodi e intaccandone sensibilmente la consistenza numerica; con due successive tornate portò a 600 il numero dei senatori e riempì i vuoti con homines novi a lui legati e con ex-avversari riabilitati144. Visti anche i nuovi criteri stabiliti per l’ammissione all’assemblea145, il dato non può che risultare sorprendente: la situazione finanziaria dei reintegrati all’indomani delle guerre civili era infatti tutt’altro che florida.
Estremamente eloquente in proposito la testimonianza di Seneca Padre, autore del quale sono state opportunamente valorizzate le potenzialità documentarie in relazione all’età delle guerre civili146: in una delle Controversiae, un patrono riabilitato e reintegrato vive infatti un momento di gravissima difficoltà economica. Pur avendo rinunciato alle operae del liberto presso il quale aveva trovato rifugio da proscritto, si trova costretto a reclamarle, dal momento che le guerre civili l’avevano del tutto prostrato finanziariamente147. Le conseguenze economiche delle proscrizioni non erano peraltro confinate solo all’individuo, ma avevano ripercussioni più ampie a livello sociale e politico: l’indigenza costrinse alcuni a rinunciare ai loro incarichi magistratuali148 e il figlio di Oppio, ottenuti per la pietas dimostrata nei confronti del padre pubblici riconoscimenti e l’edilità, sarebbe stato privo dei mezzi per fronteggiare le spese richieste dal suo incarico se alla miseria causata dalla confisca del patrimonio non avesse posto rimedio il popolo, operando una sorta di colletta149. Il caso di Oppio, per certi versi eccezionale, testimonia con grande efficacia come le proscrizioni con i loro risvolti patrimoniali potessero risultare gravemente afflittive per l’intera famiglia del condannato, costituendo un fattore di condizionamento non trascurabile nella composizione della classe dirigente150.
Eppure, le fonti attestano circa una trentina di casi in cui una carriera politica fu possibile anche per la discendenza dei proscritti: molti figli o nipoti di coloro che erano stati dichiarati nemici dello stato raggiunsero più tardi, per esempio, il consolato151. In un sistema che, dopo gli abusi dell’età triumvirale152, stava cercando di ripristinare la senatui maiestas153 anche attraverso la reintroduzione dei requisiti censitari, la publicatio bonorum doveva aver privato un consistente numero di famiglie di risorse imprescindibili per l’esercizio delle funzioni magistratuali154. Come fu possibile per questi soggetti il completo reintegro nel corpo politico, dato il dissesto delle finanze familiari?
Un primo fattore è rintracciabile proprio nel quadro della politica triumvirale. Cassio Dione afferma che, quasi a voler ammantare di giustizia e clemenza le loro azioni, già nel 43 a.C. furono emanate disposizioni tese a tutelare, almeno economicamente, i familiari dei proscritti. I triumviri infatti, “...annunciarono [...], come se fossero davvero giusti e umani, che avrebbero restituito alle mogli degli uccisi le loro doti e avrebbero dato un decimo dei beni paterni ai figli, alle figlie un ventesimo”155. Nelle intenzioni di Antonio, Lepido e Ottaviano, dichiarate a scopi più o meno propagandistici, la confisca dei beni non doveva dunque essere totalmente indiscriminata, ma al contrario sottoposta a una qualche forma di regolamentazione. L’attenzione dimostrata per la situazione patrimoniale dei familiari dei proscritti, con particolare riguardo alla continuità della trasmissione ereditaria, risulta senza dubbio significativa, se non addirittura sorprendente, visto il frangente di totale dissesto sociale ed economico in cui era maturata156; essa era a ogni modo il portato di precise esigenze: minare la solidarietà interna al gruppo familiare; conferire una parvenza di legittimità all’azione dei triumviri; sancire un punto di rottura rispetto al precedente delle proscrizioni sillane, il cui ricordo era ancora vivo e doloroso157. Tuttavia, dalle parole dello storico d’età severiana si intuisce come il provvedimento adottato dai triumviri abbia svolto un ruolo piuttosto marginale nel tutelare le aspettative ereditarie dei discendenti dei proscritti158. L’urgenza di accumulare denaro per sostenere la lotta contro i Cesaricidi159 e per ricompensare adeguatamente l’elemento militare alla base del loro potere160 deve aver portato i triumviri a disattendere non di rado nei fatti quanto era stato sancito a livello programmatico, allo scopo di limitare in qualche modo le pesanti conseguenze familiari delle loro azioni161.
Rispetto ai discendenti di quanti subirono l’esecuzione o scelsero la strada del suicidio che, orfani di padre, nella migliore delle ipotesi riuscirono a riottenere solo un decimo dei beni paterni, di una condizione più favorevole godettero i figli di quanti furono riabilitati con gli accordi di Miseno, nel 39 a.C.162. Questi ultimi segnarono di fatto la fine delle proscrizioni e contemplarono, su imposizione di Sesto Pompeo, specifiche disposizioni per i proscritti e per quanti avevano trovato rifugio presso di lui. Oltre al reditus, la restitutio prevista dal patto di Miseno stabiliva la riacquisizione completa dei diritti civili, solo parziale, invece, di quelli patrimoniali, consentendo il recupero di un quarto dei beni confiscati163. Dato che sedici tra i restituti raggiunsero il consolato già sotto Augusto164, i loro discendenti poterono evidentemente contare su finanze familiari già ampiamente riassestate.
In secondo luogo, nella dinamica che caratterizzava il processo di confisca165, le grandi famiglie aristocratiche poterono senza dubbio fare affidamento su una solida rete di amici, clienti e liberti: al di là degli aiuti utili a fronteggiare nell’immediato l’emergenza finanziaria, questi ultimi potevano fungere da acquirenti dei beni confiscati e messi all’asta, in vista di una futura restituzione ai proprietari originari o ai loro familiari166. Grazie all’intraprendenza e alla generosità di Attico, per esempio, il cavaliere Lucio Saufeio riuscì a recuperare integralmente le fruttuose proprietà situate in Italia, in precedenza confiscate e vendute all’asta167.
Un terzo fattore di assoluto rilievo, e sovente enfatizzato anche dalla storiografia, è costituito dalla generosità di Ottaviano, che non si limitò ad accordare il proprio favore sul piano esclusivamente politico168, ma già negli anni immediatamente successivi alla fine delle proscrizioni intervenne in prima persona a sanare le difficoltà finanziarie dei liberi proscriptorum. Stando alla testimonianza di Seneca, al figlio del pretore Lucio Cornelio Cinna, che aveva preso le parti dei Cesaricidi, venne restituito l’intero patrimonio paterno169, mentre al nipote del celebre oratore Quinto Ortensio Òrtalo, che versava in difficoltà economiche anche a causa della proscrizione del padre170, Augusto elargì ben un milione di sesterzi, purché si sposasse e avesse dei figli171: la sovvenzione era ovviamente volta a garantire che non si estinguesse una gens antica e prestigiosa, la cui presenza in senato rappresentava un fondamentale elemento di continuità con la tradizione repubblicana. Il fenomeno della liberalitas principis trova ampie attestazioni nel corso del principato augusteo, quando integrazioni al patrimonio di cavalieri e senatori, spesso in aperta connessione con la revisione delle liste del senato e con le difficoltà legate al rispetto delle nuove soglie censitarie previste, si riscontrano in varie occasioni172.
Tuttavia, ad assolvere una funzione non trascurabile per la stabilità patrimoniale familiare tra guerre civili e Principato potrebbe essere intervenuto un quarto fattore, sul quale val la pena spendere alcune riflessioni: si tratta dei patrimoni delle donne.
3b. La ricchezza delle matrone in età triumvirale
L’aneddotica relativa all’età triumvirale, pur nella tipizzazione caratteristica del genere, propone una ricca casistica di exempla di fides coniugale ai quali è opportuno non disconoscere integralmente una qualche attendibilità storica173. Il clima terroristico creato dai triumviri, attraverso la totale dissoluzione tra sfera politica e sfera domestica174 aveva infatti creato i presupposti per portare alla ribalta categorie in precedenza ai margini della tradizionale narrazione storiografica, valorizzando in particolare l’attivismo dimostrato dalle mogli a supporto dei mariti proscritti. Tra i vari casi in cui l’assistenza fornita ai coniugi assume una connotazione schiettamente materiale175, spicca senza dubbio la straordinaria testimonianza della cosiddetta Laudatio Turiae, con riferimenti agli aspetti patrimoniali della virtù della defunta176.
È possibile che, oltre a spendersi per garantire la sopravvivenza fisica dei loro congiunti, le donne con i loro patrimoni abbiano in qualche modo concorso ad assicurarne la sopravvivenza più propriamente politica, in caso di restitutio?
Per tentare di rispondere al quesito è necessario innanzitutto considerare di quali ricchezze potessero disporre le matrone nei decenni che segnarono il passaggio dalla Repubblica al Principato. Almeno nei mesi immediatamente successivi all’emanazione dell’editto di proscrizione, le donne sembrano essere rimaste in possesso di cospicui beni personali: questi ultimi, infatti, conservatisi pressoché integri in virtù della rigida separazione dei beni prevista per marito e moglie dall’ordinamento romano177, non risultano direttamente colpiti dalla publicatio bonorum178. È l’episodio di Ortensia narrato da Appiano la prova più evidente della consistenza mantenuta in questo frangente dai patrimoni femminili, i quali, non a caso, divengono oggetto delle disposizioni vessatorie dei triumviri in materia fiscale179. Proprio all’inizio del 42 a.C., infatti, Antonio, Lepido e il giovane Cesare emanarono un provvedimento straordinario volto a tassare i patrimoni femminili: effettuata una stima delle loro proprietà, 1400 matrone avrebbero dovuto contribuire alle spese militari per il pagamento dei soldati, in vista della campagna contro i cesaricidi180. L’editto scatenò la vigorosa protesta delle matronae che, presentatesi nel foro al cospetto dei triumviri181, riuscirono a ottenere un discreto successo anche grazie all’arringa pronunciata da Ortensia, figlia del celebre oratore Quinto Ortensio Òrtalo182: il numero delle contribuenti interessate dal provvedimento venne così ridotto a 400183. Il testo dello storico alessandrino è stato di recente sottoposto a riconsiderazione, con particolare attenzione proprio alle implicazioni politiche dell’intervento triumvirale184. Di certo, in un frangente di particolare criticità sotto il profilo finanziario185, interessava allargare la base dei contribuenti attingendo a un cospicuo insieme di risorse non ancora intaccate dalle politiche della nuova magistratura. Ma, soprattutto, i triumviri con ogni probabilità miravano a eliminare la base economica della fazione anticesariana prima della partenza per l’Oriente. In questo senso la decisione triumvirale denoterebbe una chiara consapevolezza da parte del potere costituito non solo dell’entità dei patrimoni femminili, ma anche della loro funzione nel quadro delle finanze familiari186. Il dato trova peraltro conferma anche nel vasto appoggio – forse decisivo nell’orientare la scelta dei triumviri – incontrato dalla protesta: le istanze delle matronae godevano del supporto di una compagine sociale più ampia rispetto al solo ordo matronarum187. La percezione della folla, verosimilmente, era che con il loro status personale sarebbe stato compromesso anche il ruolo sociale delle matronae: queste ultime, infatti, con la loro capacità patrimoniale, cooperavano attivamente anche al mantenimento della dignitas familiare. Indirettamente, dunque, erano proprio gli interessi delle rispettive familiae quelli che le donne stavano tentando di difendere, assieme ai propri188, sfruttando quale argomento principe a sostegno della non imponibilità dei loro patrimoni proprio la peculiarità della loro condizione sociale e giuridica, che aveva nell’esclusione dai virilia officia e dalla sfera politica un tratto distintivo189.
Per quanto concerne gli aspetti più propriamente fiscali, invece, sembra probabile che i triumviri non siano intervenuti operando semplicemente una riduzione del numero delle destinatarie della tassazione, ma abbiano altresì alterato la natura stessa della misura: a un primo provvedimento di natura punitiva e vessatoria190, rivolto genericamente alle 1400 matrone più facoltose e destinato a incidere in modo totalmente arbitrario sulle loro sostanze, ne sarebbe seguito un secondo che, individuata una platea di destinatarie più ristretta sulla base di più rigorosi criteri censitari, si sarebbe collocato in seno a un più ampio e organico pacchetto di riforme rivolto indistintamente a uomini e donne; questo secondo provvedimento, inoltre, avrebbe inoltre definito più chiaramente l’ammontare dell’esazione191. In base alla testimonianza di Appiano, le matronae provviste di un censo superiore ai 400.000 sesterzi192 furono tenute a versare forzosamente, a titolo di prestito, il cinquantesimo del patrimonio e un contributo per le spese di guerra pari alla rendita di un anno193.
Difficile valutare l’effettiva incidenza della disposizione, soprattutto in assenza di esplicite testimonianze. Stando a Cassio Dione, peraltro, la procedura di autovalutazione e autodenuncia dei patrimoni richiesta dai triumviri si prestava a facili contestazioni, rendendo la contribuzione di fatto assai più onerosa rispetto a quanto previsto formalmente194. Tuttavia, se si accetta l’ipotesi di una rimodulazione dell’intervento, si potrebbe ritenere che nel frangente delle proscrizioni anche le matronae tassate non siano state colpite in modo indiscriminato, e che nel corso dell’età triumvirale almeno una parte della ricchezza di cui disponevano possa essersi conservata nelle loro mani195.
Per quanto concerne la dote, si è visto come, in base a Cassio Dione, l’arbitrarietà degli interventi triumvirali in materia fiscale abbia limitato la possibilità di fare affidamento con certezza su di essa196. È tuttavia significativo che già prima dell’inizio della guerra di Perugia Ottaviano, nel tentativo di placare l’aristocrazia colpita dagli espropri, “si astenne dal confiscare le proprietà dei senatori [...] ed evitò di prendere le terre che le donne avevano avuto come dote”197. L’ambiguità che caratterizzava lo statuto della dos nel corso dell’unione matrimoniale198 deve aver reso senz’altro complessa, talvolta, la tutela dell’integrità di questa parte significativa dei beni dell’uxor199. A ogni modo, il fatto che nell’arringa di Ortensia essa figuri esplicitamente tra i possessi delle matronae, utile nell’ottica triumvirale al fine della contribuzione200, induce a ritenere che la misura a tutela della dote dovesse aver trovato comunque una sua applicazione: se le doti delle mogli dei proscritti fossero state indiscriminatamente colpite da confische, un accenno alla loro perdita sarebbe stato senz’altro utile e pertinente nel quadro della protesta201. Nell’attivo patrimoniale di una donna, comunque, il valore di beni dotali era tendenzialmente inferiore rispetto al resto dei bona sui quali una filia familias poteva vantare delle aspettative ereditarie202, ed è dunque probabile che negli assetti proprietari matronali un peso decisivo abbiano assunto i cespiti extra-dotali.
Le dinamiche che hanno interessato la trasmissione dei patrimoni delle dame della tarda Repubblica restano di fatto inattingibili nella loro complessità203. Confische e tassazioni avranno senz’altro costituito fattori di condizionamento di importanza capitale, ma altre variabili di non semplice individuazione saranno intervenute a influenzare il processo204. A titolo esemplificativo, si pensi che per le destinatarie dell’esazione straordinaria stabilita dai triumviri nel 42 a.C. l’appartenenza a una medesima fascia censitaria non implicava di per sé una totale omogeneità delle situazioni patrimoniali, profondamente diverse a seconda dell’età anagrafica e dello status familiae delle interessate: non poca differenza doveva intercorrere tra l’autonomia patrimoniale goduta da una vedova o da una divorziata ultracinquantenne, sui iuris oramai da lungo tempo, e quella invece acquisita da una giovane figlia solo alla morte del paterfamilias, con ripercussioni di non poco conto sulla capacità di serbare le sostanze familiari205. Fra gli sporadici esiti di processi di trasmissione dei grandi patrimoni aristocratici di cui è possibile seguire almeno in parte le tracce, a ogni modo, la possibilità che le ricchezze femminili abbiano quantomeno concorso a garantire ai restituti e ai loro discendenti una certa continuità sul piano economico e politico, pur non accertabile a causa delle reticenze delle fonti, pare costituire più di una semplice ipotesi206.
Se la ricchezza di Ortensia non fu sufficiente ai discendenti di Quinto Ortensio Òrtalo per mantenere il loro rango in età augustea207, l’immagine che Tacito restituisce di Giunia Terza, sorellastra di Bruto e moglie di Gaio Cassio Longino, è quella di una matrona facoltosa: morta a più di novant’anni dopo una lunga vedovanza, la donna trascurò deliberatamente nel proprio testamento l’imperatore Tiberio, onorando invece con legati tratti dalle sue magnae opes tutti gli esponenti più in vista dell’aristocrazia del tempo, tra i quali vi era forse anche un discendente del marito destinato al consolato208.
L’apporto di Mucia, matrigna di Sesto Pompeo, nel risollevare le sorti degli Emilii Scauri, potrebbe non essersi limitato alle sue indubbie qualità di mediatrice209. Nonostante Marco Emilio Scauro, antoniano condannato a morte dal giovane Cesare e graziato in virtù dell’intercessione materna210, non sia riuscito ad accedere al consolato in età augustea, al nipote della donna non mancarono i mezzi per procedere nell’ascesa magistratuale: sotto Tiberio, Mamerco non solo raggiunse il consolato nel 21 d.C., ma fu in grado di guadagnare una notevolissima influenza211. Anche le ricchezze di un’altra delle matrone scese in piazza al seguito di Ortensia212, Terenzia, ebbero certamente una loro importanza per il futuro del figlio. Tra i membri dell’aristocrazia riabilitati da Ottaviano, le fonti comprendono il nome di Marco Tullio Cicerone iunior, inserito al pari del padre nelle liste di proscrizione213. Il giovane, nonostante i trascorsi prima al fianco di Pompeo e poi con i Cesaricidi, tornò a Roma in seguito al trattato di Miseno e fu protagonista di una brillante carriera politica: pontifex e consul suffectus nel 30 a.C., assieme ad Ottaviano, sempre per volere dell’imperatore ottenne prima il governo della provincia di Siria e poi il proconsolato d’Asia, raggiungendo quindi il vertice del cursus honorum214. Ammesso e non concesso che Marco abbia potuto far valere le proprie aspettative ereditarie sui beni paterni, si trattava comunque solo di una minima parte del patrimonio di Cicerone215. Per quanto riguarda poi il recupero dei beni personali, va rammentato che fino alla morte del padre egli era ancora nella condizione di filius familias: pur beneficiando di una certa autonomia economica grazie al peculium, il fatto che la titolarità giuridica di quest’ultimo spettasse al padre avrà probabilmente complicato ogni rivendicazione su quei beni216. Peraltro, anche lo zio paterno, figura che, almeno sotto il profilo giuridico, avrebbe dovuto fungere da punto di riferimento per il giovane dopo la perdita del padre, era caduto vittima delle proscrizioni nel 42 a.C., assieme al cugino217. La posizione finanziaria di Marco potrebbe senza dubbio aver beneficiato della vicinanza a Ottaviano, anche grazie alla decisiva mediazione di Agrippa, legato fino al 28 a.C. alla figlia del vecchio amico del padre, Attico218; malgrado ciò, manca nelle fonti un’attestazione esplicita di un intervento diretto del princeps a supporto del giovane. Date queste premesse, anche alla luce delle testimonianze presenti nell’epistolario ciceroniano in merito alle qualità amministrative e gestionali della donna219, è altamente probabile che un ruolo di primo piano sia stato svolto da Terenzia: se la fama del padre giocò certamente un ruolo fondamentale nella progressione della sua carriera220, fu con ogni probabilità alla madre che Marco dovette il supporto finanziario indispensabile per affrontare gli anni intercorsi tra il reintegro e il consolato221.
Pure Quinto Lucrezio Vespillone riuscì, piuttosto tardivamente, nel 19 a.C., ad accedere al consolato222. Reintegrato completamente da un punto di vista civico, certamente avrà sofferto delle difficoltà finanziarie connesse con la condizione di restitutus, che gli consentiva il recupero solo di un quarto dei propri beni223. Anche se non volessimo prudentemente ascrivere a Turia, sua moglie, le qualità elogiate nella celeberrima anonima iscrizione224, è verosimile che presso la consorte Vespillone possa aver trovato molto più di un nascondiglio225.
L’età della rivoluzione romana dovette conferire alla capacità patrimoniale delle donne un rilievo di primo piano. Presente durante la pubblica protesta perorata da Ortensia226, e coinvolto in prima persona nel reintegro politico dei suoi ex-avversari, Augusto ebbe senz’altro modo di misurarsi direttamente non solo con il coraggio e l’intraprendenza di molte matrone, ma anche con la loro ricchezza e la loro autonomia finanziaria. Proprio il ruolo sociale ed economico svolto negli anni travagliati delle guerre civili da queste donne – e da molte altre delle quali non ci è giunta notizia – potrebbe dunque aver reso evidente agli occhi del princeps come quella svolta dall’elemento femminile per la continuità familiare fosse una funzione assolutamente irrinunciabile, palesando l’opportunità di un pieno coinvolgimento delle donne nel suo programma legislativo.
Non si dimentichi, infine, che di uno di questi modelli di virtù muliebre Augusto fece sua moglie, apprezzando molto da vicino il valore cruciale assunto dall’elemento femminile nella trasmissione dei bona familiari. Figlia di Marco Livio Druso Claudiano e già moglie di Tiberio Claudio Nerone, proscritto nel 43 a.C.227, Livia discendeva da una famiglia anticesariana ostile al triumvirato e a Ottaviano fin dai tempi della guerra di Perugia. Il suo matrimonio con Ottaviano, nel 38 a.C., orientava quest’ultimo verso le tradizioni aristocratiche dell’antica nobilitas repubblicana, alla ricerca di un accordo con gli esponenti di quella frangia nobiliare che gli era stata sfavorevole228. Il padre di Livia era morto suicida a Filippi229, mentre l’ex-marito era stato partigiano prima, nella guerra perugina, di Lucio Antonio, poi, fuggito in seguito alla vittoria di Ottaviano e rifugiatosi in Sicilia, di Marco Antonio230. Le fonti attribuiscono alla donna immense ricchezze, ma la sua situazione patrimoniale dovette subire un forte contraccolpo con la proscrizione del padre: alla morte di quest’ultimo, Livia si trovò probabilmente privata di gran parte delle aspettative successorie sul patrimonio paterno e, al contempo, sposata con un restitutus231. Proprio la volontà di poter accedere all’asse ereditario dei Livii Drusi potrebbe aver costituito il movente fondamentale del matrimonio con Augusto, avvenuto con la complicità di Tiberio Claudio Nerone, anche nell’interesse dei figli232. Nonostante l’assoluta eccezionalità della loro posizione, destinata a godere del decisivo favore del patrigno, la stabilità patrimoniale di Tiberio e Druso aveva trovato nell’intraprendenza della madre e nelle cospicue risorse da lei ereditate una prima importante garanzia. Da questo punto di vista, l’esenzione dalla tutela muliebris conferita alla moglie di Augusto già nel 35 a.C.233 costituiva non una vacua onorificenza, ma un provvedimento ad hoc connesso alle precise esigenze della donna, desiderosa di amministrare in piena libertà il cospicuo patrimonio tornato a sua disposizione, nonché il significativo antecedente della capacità di agire concessa alla mater dalla legislazione augustea con il conferimento del ius liberorum.
4. Conclusioni
Prima di diventare un modello dotato di cogenza normativa attraverso la legislazione augustea, l’ideale della materfamilias aveva dispiegato sul terreno della storia la sua importanza sociale e civile quale custode dell’integritas morale e patrimoniale della famiglia. Negli anni delle guerre civili e delle proscrizioni, la totale e subitanea perdita dei diritti civili e politici da parte del paterfamilias, punto di riferimento giuridico, sociale e patrimoniale per coloro che erano sottoposti alla sua patria potestas, da un lato aveva aperto nuovi varchi per un maggiore attivismo femminile sulla scena pubblica234, dall’altro aveva palesato la rilevanza del contributo patrimoniale delle donne non solo nell’immediato, a supporto dei parenti proscritti o in qualità di contribuenti nell’ambito della politica fiscale dei triumviri, ma anche quali protagoniste nella conservazione e nella trasmissione dei patrimoni familiari.
L’interesse del princeps all’integrità, oltre che demografica e morale, anche patrimoniale degli ordini superiori, e con esso la consapevolezza della necessaria inclusione dell’elemento femminile nella realizzazione dei suoi scopi etici e sociali, potrebbe dunque aver verosimilmente trovato proprio negli anni immediatamente successivi alle guerre civili un contesto di sviluppo particolarmente fertile, capace di esercitare un influsso di non poco conto sulle modalità adottate nel concreto per attuare il suo progetto normativo.
Senza affrontare nel merito il tema dell’efficacia della legislazione, al centro di un dibattito storiografico tutt’altro che sopito235, e circoscrivendo dunque la riflessione all’impatto da essa esercitato sulla capacità patrimoniale femminile, risulta arduo determinare in che misura la norma giuridica abbia effettivamente inciso sulla prassi sociale, soprattutto se si considera che la condizione della donna appare ben definita in termini di indipendenza economica e capacità di agire già negli ultimi decenni della Repubblica236. Sotto questo profilo, l’intervento legislativo di Augusto si sarebbe limitato a riflettere una realtà di fatto, sanzionandola da un punto di vista normativo: l’importanza sociale ed economica che la partecipazione femminile assolveva a livello fattuale per la prosperità della domus assunse con Augusto una dimensione ufficiale, capace di trovare un riconoscimento sul piano delle formali categorie giuridiche.
Ciò nonostante, la riforma etico-matrimoniale promossa dal princeps rappresenta senza dubbio una variante significativa all’interno della dialettica di sistema tra prassi sociale, in un certo modo inclusiva, e regola di diritto, fermamente discriminatoria nei confronti del sesso femminile237, segnando un momento di netta discontinuità. Se l’attribuzione di una rilevanza pubblica alla funzione procreativa della donna non pare certo un tratto innovativo dell’intervento augusteo238, del tutto nuovo al suo interno appare l’atteggiamento verso la concentrazione di ricchezza in mano femminile, improntato a una maggiore apertura rispetto alle tendenze invalse. Anziché avvalersi di meccanismi esclusivamente proibizionistici per evitare la dispersione del patrimonio familiare, com’era accaduto in età medio-repubblicana con la lex Oppia e con la lex Voconia239, Augusto, acquisiti come dati incontrovertibili da un lato il possesso di ingenti quantitativi di ricchezza nelle mani delle donne, dall’altro la rilevanza sociale connessa alla loro funzione procreativa, optò per accelerare un processo già ampiamente in corso, elaborando uno strumento normativo che consentisse di disciplinarlo240. La subordinazione al requisito della maternità e al rispetto di un programma tanto ambizioso e rigoroso241 nell’ottica del princeps rappresentava un mezzo idoneo per scardinare il pericoloso nesso tra “emancipazione” socio-economica femminile e licenza sessuale, arginando gli effetti destabilizzanti che quest’ultimo poteva comportare nell’ambito degli equilibri proprietari; per le donne, invece, la chiave d’accesso alla possibilità di un’autonomia ragguardevole sul piano economico e sociale: preclusa da pesanti sanzioni finanziarie a quante non ottemperavano ai doveri morali e civici previsti dalla legislazione, in presenza di un’assoluta conformità agli standard ideologici e giuridici da essa fissati, tale autonomia trovava nel programma normativo augusteo un importante riconoscimento e una significativa valorizzazione.