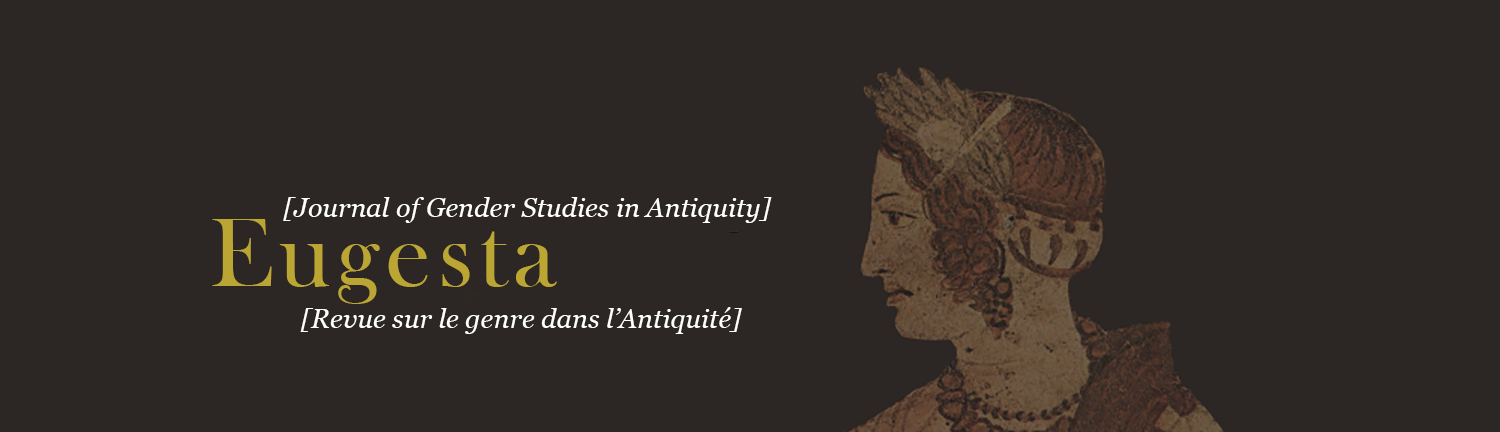Presentiamo qui per la prima volta alcuni passi del testo trasmesso sotto il nome di Metrodora come anticipazione della prima edizione critica del testo che da qui a breve verrà da noi pubblicata. L’opera di Metrodora o forse sarebbe meglio dire le opere, vista l’incertezza in merito alla sua produzione, si conserva solo parzialmente e tramite le porzioni di testo che si sono conservate possiamo affermare che l’autrice si sia occupata di ginecologia e di ostetricia, di cosmetica e forse anche che abbia scritto un’opera di carattere iologico. L’opera o le opere di Metrodora hanno sicuramente avuto fortuna nel panorama della letteratura medica, come dimostra il fatto che numerosi estratti siano stati copiati fino al XVI secolo. Durante il lavoro di edizione abbiamo identificato due nuovi testimoni manoscritti – un codice conservato alla BNF (Par. Gr. 2243 del XIV secolo) e un codice conservato presso la Biblioteca Centrale Regione Siciliana di Palermo (Pan. Gr. XIII C3 del XVI secolo) – e altresì individuato alcuni passi in un manoscritto conservato presso la Biblioteca Apostolica Vaticana (Vat. Gr. 299 del XIV secolo) che si vanno ad aggiungere a quelli già identificati da De Lucia1 e ai due passi in un altro manoscritto della BNF (Par. Gr. 2194 datato al XV secolo) identificati da Ieraci Bio2.
Ci soffermeremo su alcune ricette cosmetiche utili, a nostro avviso, a precisare alcuni aspetti relativi alla figura di Metrodora e al milieu culturale nel quale è vissuta e soprattutto al suo rapporto con la medicina greca e in particolare con la farmacologia. I passi proposti saranno presentati come figureranno nell’edizione, cioè in frammenti. Questa scelta editoriale dipende dalla trasmissione frammentaria dell’opera; i manoscritti infatti tramandano soltanto degli estratti dell’opera o delle opere.
1. L’opera di Metrodora e la medicina greca
Charles Daremberg3 nel 1851 fu il primo a porre in risalto l’importanza dell’opera di Metrodora per quando riguarda la ginecologia antica affiancandola a quella di Sorano e Moschione. Nonostante il celebre studioso francese avesse collocato l’opera di Metrodora nella tradizione medica greca annoverandola nel suo piano di pubblicazione dei medici greci e latini, gli studi successivi hanno relegato la sua opera in un angolo di subalternità. Dobbiamo infatti aspettare quasi un secolo per la pubblicazione di una prima trascrizione del testo realizzata da Kousis nel 19454. Lo studioso greco trascrive il contenuto dei fogli 4v-33r di un manoscritto oggi conservato presso la biblioteca Laurenziana (Laur. Plut. 75.3). Si tratta di un codice antico, datato tra la fine del X e l’inizio dell’XI secolo5; esso tramanda alcuni estratti da un trattato medico attribuito a Metrodora come si evince dall’incipit: ’Eκ τῶν Μητροδώρας / Dai libri di Metrodora. Il titolo dell’opera o delle opere di Metrodora ci è ignoto. A nostro avviso infatti il titolo del primo capitolo – Περὶ τῶν γυναικείων παθῶν τῆς μήτρας / Sulle malattie femminili dell’utero – è stato indicato erroneamente come titolo dell’intera opera da tutti gli studiosi che si sono occupati di questo testo6. Questo ha generato non poca confusione sull’effettiva letteratura medica scritta da Metrodora, circoscrivendone gli interessi all’ambito della ginecologia.
Gli scritti ginecologici di Metrodora ampliano le nostre conoscenze sulla ginecologia antica, della quale abbiamo poche testimonianze: i trattati nel Corpus Hippocraticum, l’opera di Sorano e altri frammenti da opera perdute, ad esempio tre ricette di Olimpiade di Tebe7 nella Naturalis Historia di Plinio. Metrodora tuttavia, come si è detto, non si è occupata soltanto di ginecologia e in questo non rappresenta affatto un’eccezione. Nel mondo greco-latino, per citare solo alcuni esempi, Samithra, Xanite e Favilla8 sono da considerarsi autrici di ricette da ascriversi alla farmacologia. Tali ricette sono sopravvissute in quanto utilizzate da Galeno. Nel trattato De compositione medicamentorum secundum locos due ricette per la cura delle patologie del tratto anale ritenute entrambe πολύχρηστος (“molto utili”) sono attribuite dal medico di Pergamo la prima a Samithra9, la seconda a Xanite10. Le ricette figurano in una sezione del capitolo 6 del libro nono che ha come fonte Andromaco il Giovane11, il quale annovera tra gli autori, oltre a Samithra e Xanite, anche il celebre Erofilo12. Anche Favilla è una fonte del De compositione medicamentorum secundum locos; Galeno le ascrive due rimedi13, il primo per problemi alla milza14, il secondo per patologie reumatiche15. Non dovrebbero dunque esistere (più)16 dubbi sul fatto che queste donne hanno avuto un posto di rilievo nella tradizione farmacologica. Ciò che rimane di queste autrici e di Metrodora ci consente di studiare come le donne hanno contribuito alla storia della medicina e della farmacologia e dovrebbe, a nostro avviso, suscitare il desiderio di ricostruire la loro produzione medica in parte perduta e, al contempo, approfondire le nostre conoscenze sulla storia dell’educazione riservata alle donne nel mondo antico17.
2. Metrodora e Alessandria
L’attribuzione a un’autrice chiamata Metrodora del testo riportato dal Laurenziano è stato oggetto di un lungo dibattito. Dean-Jones ha espresso perplessità sul fatto che una donna possa avere scritto di medicina18; Flemming ha ritenuto che ‘Metrodora’ sia un nome parlante per “doni della madre” e che dunque l’ambiguità di tale nome metta in discussione l’attribuzione di questo trattato ad una donna19. Nelle moderne enciclopedie non si trovano appigli per sciogliere questa ambiguità: ad esempio Touwaide20 afferma che Metrodora non sia il nome dell’autore, ma il titolo dell’opera, cioè ‘i doni della madre’, pertanto una collezione ano-nima di testi. Va tuttavia notato, come è stato giustamente sottolineato21, che il nome proprio Metrodora è un teoforico come Teodora o Apollodora ed è in uso dal IV secolo a.C. fino al I d.C. (cfr. LGPN). Oggi sulla base delle nostre nuove acquisizioni, delle quali daremo conto in dettaglio nell’introduzione all’edizione, riteniamo che questa querelle sull’identità di Metrodora può considerarsi risolta. Il fatto che nel manoscritto vaticano figuri due volte il nome di Metrodora come autrice delle ricette riportate (la prima nel foglio 462r; la seconda nel foglio 506r) chiarisce che il compilatore del vaticano ha attribuito ad un’autrice di nome Metrodora i passi riportati.
Sul periodo in cui Metrodora pratica e scrive di medicina le posizioni sono discordanti e anche su questo importante aspetto offriamo alcuni dati, sperando che essi possano essere utili al lettore. Le datazioni proposte oscillano tra il I secolo d.C. e il VI d.C. Deichgräber22 ne ipotizza l’attività nel tardo ellenismo, pur non nascondendo le proprie perplessità, vista l’esiguità dei dati a supporto di questa ipotesi. Kousis23, seguito dal Del Guerra, propone una datazione al VI secolo d.C. sulla base di una presunta citazione da Alessandro di Tralle24, medico attivo nel VI secolo e fratello di Antemio di Tralle, architetto della basilica di Hagia Sophia. Parker25 propone un periodo che potrebbe andare dal II al IV secolo d.C. con una approssimazione di un secolo in più o in meno, sostendo che il linguaggio medico di Metrodora non aiuti a precisare la datazione. Il nostro lavoro filologico sulla lingua di Metrodora e le fonti citate nella sua opera ci consentono di avanzare l’ipotesi di datazione in età imperiale e di collocazione ad Alessandria. Forniremo qui, a titolo di esempio e senza la pretesa di esaustività, alcuni dati ricavati dal testo che rimandano all’ambiente di Alessandria in età imperiale.
In merito alla lingua utilizzata ci pare opportuno presentare quello che sarà il frammento 20 della nostra edizione:
Πεσσὸς συλληπτικὸς σατύριος καλούμενος.
Kηροῦ τυρρηνικοῦ οὐγκίας γ’, ἐλαίου παλαιοῦ οὐγκίας γ’, τερεβινθίνης καθαρᾶς ὁμοίως, ἀφρονίτρου καλοῦ οὐγκίαν α’, τήλεως ἀλεύρου οὐγκίαν α’, τὸ ἀφρόνιτρον καὶ τὴν τῆλιν λεῖαν μίσγε τοῖς τηκτοῖς καὶ ποιήσας πεσσὸν προστίθει.
Ἄλλο·
Σατυρίου σπέρματος δραχμὰς δ’, μέλιτος Ἀττικοῦ δραχμὰς δ’, χολῆς δορκάδος τὸ ὑγρὸν ὅσον ἔχεις, μίξας καὶ ποιήσας πεσσὸν προστίθει.
Ἄλλο·
Πορφύραν ἀληθινὴν βρέξον εἰς χολὴν αἰγείαν καὶ ἐπίθες εἰς τὸν ὀμφαλὸν τῆς γυναικὸς ἐπὶ ἡμέρας ζ’ καὶ συγγενέσθω τῷ ἀνδρὶ σελήνης αὐξιφωτούσης26.
Pessario per concepire facilmente detto satirio:
3 once di cera etrusca, 3 once di olio vecchio, trementina pura in parti uguali, 1 oncia di salnitro di buona qualità, 1 oncia di farina di fieno greco, mescola il salnitro e il fieno greco in polvere con gli ingredienti sciolti, fai un pessario e applica.
Altra ricetta:
4 dracme di seme di satirio, 4 dracme di miele attico, succo di bile di capriolo quanto ne hai a disposizione; mescola, fai un pessario e applica.
Altra ricetta:
Immergi della porpora pura in bile di capra e ponila sull’ombelico della donna per 7 giorni, e che ella abbia rapporti con il marito quando la luna aumenta la sua luce. [Trad. nostra]
Particolarmente significativo, a nostro avviso, è l’uso nell’ultimo rigo del participio αὐξιφωτούσης (“aumentare la luce”), lectio difficilior per αὐξούσης (“accrescere, aumentare”). Si tratta di un verbo proprio esclusivamente del linguaggio astronomico, che occorre nell’opera di Vettius Valens (II d.C.) e in quella di Doroteo (I secolo d.C).
Un esempio poi sull’uso di testi prodotti ad Alessandria ci è parso di una qualche importanza. A titolo di esempio, il contenuto del frammento 3 è analogo ad un passo di Elio Promoto Alessandrino, fatto questo che ci permette di ipotizzare o che Metrodora abbia utilizzato Elio Promoto o che entrambi abbiano utilizzato la stessa fonte27:
|
Metrodora fr. 3 |
Elio Promoto, Dynameron 26.10 |
|
Ἄλλο ὥστε ὑλακτεῖν καὶ παντοίας φωνὰς ἀποτελεῖν. |
Ἠδονικὸν θαυμαστόν, ὥστε ὑλακτεῖν καὶ παντοίας φωνὰς ἀποπέμπειν τὴν γυναῖκα ἐκ τῆς ἡδονῆς. |
|
Altra ricetta per fare emettere guaiti e produrre grida di ogni genere. |
Afrodisiaco meraviglioso, tale che la donna ululi e emetta gemiti di ogni sorta per il piacere. |
Come si evince dal confronto tra i due testi si tratta della stessa ricetta. Gli ingredienti sono gli stessi e non compaiono significative differenze nella posologia. Interessante invece la differenza nel titolo. La presenza di ἄλλο (“altro”) in Metrodora fa pensare che la ricetta facesse parte di una sezione comprendente più di una ricetta, e come abitualmente accade, le ricette successive alla prima sono semplicemente introdotte da ἄλλο, invece di riportare nuovamente il titolo. Si tratta inoltre, è bene sottolinearlo, di una ricetta che non viene altrove menzionata.
Metrodora non è l’unica donna che studia e scrive ad Alessandria. La presenza di erudite è attestata in ambito alessandrino almeno dal II-III secolo a.C.. Ricordiamo, a titolo di esempio, la grammatichessa Estiea, che si occupò molto probabilmente anche di geologia31, e la matematica Pandrosion, a cui Pappaus dedicò il terzo libro delle Collectiones Matematicae32.
3. Metrodora e la tradizione cosmetica
L’interesse di Metrodora per la cosmetica segue una tradizione consolidata e presente nella medicina greca. In un passo tramandato da Galeno, Sorano di Efeso ricorda i primi autori di opere cosmetiche, Asclepiade, Eraclide di Taranto, Elefantide e Moschione:
γέγραπται δὲ καὶ ἄλλα πολλὰ, φησὶν, παρά τε Ἀσκληπιάδῃ καὶ Ἡρακλείδῃ τῷ Ταραντίνῳ καὶ Ἐλεφαντίδῃ καὶ Μοσχίωνι διὰ τοῦ κοσμητικοῦ ἐξ ὧν ἔγραψε καὶ αὐτὸς τά θ’ ὑπ’ Ἀσκληπιάδου προγεγραμμένα καὶ ἄλλα τινὰ ὧν ἐφεξῆς μνημονεύσω33.
Sono state scritte anche molte altre ricette, come dice [Sorano], in Asclepiade, Eraclide di Taranto, Elefantide e Moschione nella cosmetica dalle quali egli stesso ha scritto quelle che sono state trascritte sopra da Asclepiade e alcune altre le ricorderò di seguito34.
[Trad. nostra]
Questo testimonia la stretta connessione della cosmetica con la farmacologia. Galeno ricorderà poi opere a lui più vicine quali quelle di Cleopatra e di Critone. L’opera di Cleopatra ebbe un’ampia diffusione come dimostra la sua presenza in Galeno e la sua circolazione almeno fino alla tarda antichità. Questo purtroppo non ne ha impedito la perdita tanto che oggi possiamo leggerne solo alcuni frammenti35 dal perduto trattato intitolato Kosmetikón36, nelle opere di Galeno e di due medici della tarda antichità, Aezio di Amida attivo nel VI secolo e Paolo Egineta nel VII secolo. Anche la produzione di Critone37 ci è nota per tradizione indiretta. Medico personale dell’imperatore Traiano, con la qualifica di archiatra, come attestasto da una testimonianza epigrafica (MAMA VI, 91,7)38, ha esercitato la professione medica tra il I e il II secolo d.C., prevalentemente a Roma. Fu autore di almeno due trattati, uno intitolato Περὶ (ἁπλῶν) φαρμάκων / Sui farmaci (semplici), in cinque libri, l’altro dal titolo Κosmetiká in quattro libri39. Il trattato sulla cosmetica ha avuto un’ampia circolazione: Galeno riporta integralmente l’indice dei quattro libri; numerose ricette si leggono in Galeno e in altri autori, ad esempio in Aezio di Amida. L’opera si conserva solo indirettamente e quindi in modo frammentario; ad oggi l’edizione dei frammenti resta un desideratum.
I passi cosmetici conservati sotto il nome di Metrodora riguardano la cura del seno40, del viso41, delle mani, piedi e collo42 e infine un profumo per il corpo43. Presentiamo in questa sede il frammento 38 in cui si cita la regina Berenice e il frammento 49 per il quale discuteremo i rapporti con Critone.
Il frammento 38 intitolato Πρὸς πρόσωπον λαμπρὸν ποιῆσαι / “Per rendere il viso luminoso” amplia le nostre conoscenze sulla tradizione cosmetica, restituendoci una ricetta attribuita a Berenice:
<Πρὸς> πρόσωπον λαμπρὸν ποιῆσαι.
Τούτῳ ἐχρήσατο Βερονίκη ἡ βασίλισσα τῆς Αἰγύπτου ἡ μετακληθεῖσα Κλεοπάτρα.
Ἐλάφειον κέρας βαλοῦσα εἰς χύτραν καινὴν ὤπτησεν εἰς κάμινον καὶ ἐξελοῦσα εὗρεν κατάλευκον· τοῦτο λειώσασα μετὰ γάλακτος ἐχρίετο <τὸ πρόσωπον>.
Ἄλλο·
Μελάνθιον καὶ τῆλιν καὶ λινόσπερμα λειώσας σὺν οἴνῳ εὐώδει κατάπλασσε44.
Per rendere il viso luminoso.
Ne ha fatto uso Berenice, la regina d’Egitto che fu anche chiamata Cleopatra. Mise un corno di cervo in una pentola nuova, lo fece cuocere su un fornelletto e, tiratolo fuori, scoprì che era diventato bianchissimo. Dopo averlo emulsionato con del latte, lo usava per spalmare il viso.
Altra ricetta:
Emulsiona cumino nero, fieno greco e semi di lino con vino profumato e applica un cataplasma.
[Trad. nostra]
Le informazioni contenute nel frammento, cioè che Berenice fu regina di Egitto e che venne anche chiamata Cleopatra, ci porta a supporre che con tutta probabilità si possa trattare di Berenice III, moglie di Tolomeo X, morta nell’80 a.C. Questa ipotesi è supportata da fonti epigrafiche e papiracee secondo le quali Berenice III era chiamata anche Cleopatra45. Nella letteratura medica non si conoscono finora altre ricette attribuite a Berenice, mentre invece di quelle attribuite a Cleopatra abbiamo già detto. Il riferimento a Berenice come autrice di una ricetta cosmetica aggiunge ulteriori dubbi sull’attribuzione a Cleopatra VII del trattato Kosmetikón46.
La ricetta qui riportata entra pienamente nel campo della farmacologia: l’ ingrediente, ossia il corno di cervo, la terminologia usata, ad esempio l’aggettivo κατάλευκος -ον (“bianchissimo”), gli strumenti impiegati nella preparazione, si veda l’uso della χύτρα, “pentola per la preparazione di rimedi medicinali” (cfr. Montanari), e non ultimo il metodo. Il corno di cervo è un ingrediente molto utilizzato in farmacologia, sia da solo che con altri ingredienti per la cura di diverse patologie; figura in diverse tipologie di rimedi quali ad esempio colliri, decotti, bevande e unguenti. È evidente che si tratti di un ingrediente molto pregiato e talvolta difficile da reperire tanto che al suo posto viene comunemente impiegato il corno di capra47. In due opere del Corpus Hippocraticum, i trattati De natura muliebri e De mulierum affectibus, questo ingrediente è usato sia da solo che con altri ingredienti, somministrato come decotto, bevanda o suffumigio per la cura di malattie dell’utero e del flusso mestruale48. Nel trattato De materia medica di Dioscoride Pedanio (I d.C.) abbiamo due occorrenze: una per la cura dei reni e della vescica49, l’altra per la cura di diverse affezioni tra cui la dissenteria, dolori alla vescica, occhi infiammati e mal di denti:
ἐλάφου κέρας κεκαυμένον καὶ πεπλυμένον ἁρμόζει πλῆθος πινόμενον κοχλιαρίων δυεῖν αἱμοπτυοικοῖς, δυσεντερικοῖς, κοιλιακοῖς, ἰκτερικοῖς, κύστεως ἀλγήμασι μετὰ τραγακάνθης, ῥοικαῖς δὲ γυναιξὶ μετὰ ὑγροῦ τοῦ πρὸς τὸ πάθος ἁρμόζοντος. Καίεται δὲ ἐν καμίνῳ καταβληθὲν καὶ κοπὲν εἰς ὠμὴν χύτραν περιπεπλασμένην πηλῷ, ἄχρι ἂν λευκὸν γένηται. πλύνεται δὲ ὡς καδμία. πὸ δὲ τοιοῦτον ἁρμόζει πρὸς τὰ ἐν ὀφθαλμοῖς ῥεύματα καὶ ἕλκη, καὶ ὀδόντας δὲ παρατριβόμενον σμήχει. ὠμὸν δὲ θυμιαθὲν ἑρπετὰ διώκει, ἀποζεσθὲν δὲ μετ᾽ὄξους καὶ διακλυζόμενον παρηγορεῖ γομφιάσεις.
An amount of two spoonsful of hart’s horn burned and washed, is a suitable drink for people who suffer in the bowles, for the jaundiced, for bladder pains with tragacanth, and for women who are having discharges with a liquid that is appropriate for their condition. After it has been placed in an unbacked clay pot and chopped up, the pot is sealed with clay and burned in an oven until the horn becomes white. It is washed like calamine. This type of preparation is suitable for eye rheums and eye sores, and it cleans the teeth when rubbed against them. Burned raw to produce thick smoke, it drives away serpents, and when boiled with vineger and used as rinse, it assuages toothaches50.
Il capitolo qui riportato presenta alcune analogie con la ricetta che Metrodora attribuisce a Berenice: la cottura nel camino, l’uso della χύτρα, utensile impiegato in farmacologia già nel Corpus Hippocraticum51, e il riferimento al colore bianco che deve avere il corno di cervo dopo averlo fatto bruciare, nonchè la sua applicazione per strofinamento. In Metrodora, per indicare il colore bianco, viene utilizzato l’aggettivo κατάλευκος -ον (“bianchissimo”) attestato in medicina solo un’altra volta nel trattato De morbis acutis et chroniis attribuito ad un anonimo medico di età imperiale52. C’è tuttavia tra queste due ricette una differenza importante. Metrodora infatti precisa che la regina Berenice, una volta estratto il corno dal camino, scoprì (εὗρεν) che era diventato bianchissimo. Questo induce a supporre che si tratti di una scoperta cosmetica che non rientrava nella tradizione farmacologica. Berenice sarebbe stata insomma la prima a pensare di utilizzare il corno bruciato di capra come sbiancante.
Con il frammento 49 introduciamo la spinosa questione del rapporto tra l’opera di Metrodora e il trattato Κosmetiká di Critone:
Εὐωδία σώματος κατάπαστος.
Ῥόδων ἀβρόχων ξηρῶν δραχμὰς μ’, σμύρνης καθαρᾶς δραχμὰς κ’, ἴρεως ῥίζης δραχμὰς ι’ λειώσας σὺν οἴνῳ εὐώδει ἀνάπλαττε τροχίσκους. Ἐπὶ δὲ τῆς χρείας οἴνῳ εὐώδει λειώσας ἀπὸ λουτροῦ κατάχριε53.
Profumo in polvere per il corpo.
40 dracme di rose non umettate e secche, 20 dracme di mirra pura, 10 dracme di radice di iris, emulsiona con vino profumato e confeziona dei trochischi. Per l’uso emulsiona con vino profumato e spalma dopo il bagno.
[Trad. nostra]
Si tratta di un profumo da applicare dopo il bagno; anche in questo caso, come per il preparato di Berenice, se ne raccomanda l’emulsione con vino profumato. Aezio di Amida (VI sec. d.C.) attribuisce una versione analoga della medesima ricetta a Critone nel capitolo intitolato Καταπλάσματα θερινὰ εὐωδίαν ποιοῦντα τῷ παντὶ σώματι Κρίτωνος / “Cataplasmi estivi che profumano ogni parte del corpo, da Critone”:
Καταπαστὸν ὅλου τοῦ σώματος, ἐν ᾧ βούλει χρήσασθαι καιρῷ, εὐῶδες προσηνές. ῥόδων χλωρῶν ἀβρόχων δραχμὰς μ’, σμύρνης τρωγλίτιδος, ἴρεως Ἰλλυρικῆς, ναρδοστάχυος, κασσίας, ἀνὰ δραχμὰς η’, οἴνῳ εὐώδει φυράσας ἀνάπλαττε τροχίσκους· ἐπὶ δὲ τῆς χρείας κόπτων καὶ σήθων κατάπλασσε τὸ σῶμα, μάλιστα μετὰ τὸ λουτρόν54.
Rimedio in polvere per tutto il corpo, che puoi usare quando lo ritieni opportuno, dal buon odore gradevole. 11 dracme di rose tenere non umettate, mirra troglite, iris illirica, spiga di nardo, cassia, di ciascuno 8 dracme, mescola con vino profumato, confeziona dei trochischi. Per l’uso falli a pezzettini, setacciali e spalma il corpo, soprattutto dopo il bagno.
[Trad. nostra]
Appurato che Aezio cita Critone, restano da chiarire i rapporti tra lo stesso Critone e Metrodora alla luce delle somiglianze tra le due ricette. La versione di Critone ha due ingredienti aggiuntivi rispetto a quelli di Metrodora, la spiga di nardo e la cassia, e poche altre differenze testuali significative. Il nome del rimedio, ovvero καταπάστος (“rimedio in polvere”), la maggior parte degli ingredienti, l’emulsione con vino profumato, la preparazione in trochischi, l’applicazione su tutto il corpo dopo il bagno ci permettono di formulare le seguenti ipotesi: uso di una fonte comune, rielaborazione da parte di Critone del testo di Metrodora, la semplificazione da parte di Metrodora del testo di Critone con l’esclusione della spiga di nardo e della cassia. Questa ricetta, così come le altre ricette cosmetiche nei frammenti superstiti di Metrodora, ci testimonia l’esistenza di una tradizione cosmetica e farmacologica ad oggi perduta e in parte ricostruibile attraverso la tradizione indiretta.
Conclusioni
La perdita di numerose opere prodotte dalla civiltà greco-romana ha riguardato anche numerosi testi medici, per i quali non ci restano che frammenti; si pensi, a titolo di esempio, all’opera di Archigene di Apamea (II secolo d.C.). L’opera di Metrodora è stata salvata dall’oblio da alcuni anonimi compilatori che nel corso dei secoli ne hanno citato l’opera conservando il nome dell’autrice. I passi che qui abbiamo discusso ci hanno permesso di fornire alcuni dati sul rapporto tra Metrodora e la tradizione medica e sul possibile milieu culturale nel quale ha potuto operare l’autrice, verosimilmente in Egitto, forse ad Alessandria, probabilmente in età imperiale e non nel tardo-antico, come si è pensato per lungo tempo. A nostro parere, l’opera o le opere di Metrodora possono considerarsi opere nel solco della tradizione medica inaugurata da Ippocrate, la presenza di ricette cosmetiche e non commotiche ne è un chiaro indice. Tramite lo studio e l’analisi dei passi sopravvissuti ci è possibile acquisire nuovi dati sulla cosmetica, tramite il rapporto che essi hanno con la perduta opera di Critone, e anche per questa ragione auspichiamo che il suo studio possa portare nuovi e interessanti dati per ampliare la nostra conoscenza della medicina greca.